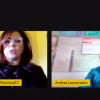Nel 1887 la giornalista Nellie Bly si fece internare, da infiltrata per il New York World (diretto da Joseph Pulitzer), in un ospedale psichiatrico. Per l’epoca il resoconto, divenuto poi il libro Ten days in a Mad-House fu uno scandalo, sia perché redatto da una donna, sia perché per la prima volta metteva in luce la disumanità in cui vivevano le pazienti ricoverate al manicomio femminile di Blackwell’s Island. Scoprì che alcune di esse erano completamente sane di mente e credute folli dalla società, emarginate perché non avevano un marito o non erano “madri perfette” secondo gli standard dell’epoca: la sua inchiesta fu utile a raccogliere fondi per migliorare le condizioni di vita delle pazienti, che erano costrette ad assumere droghe, mangiare cibi marci, ed essere immerse nell’acqua gelida.
Oggi come Nellie, voglio condurre un’inchiesta, di duplice valenza, utile ad analizzare la società in cui mi trovo e me stessa. Non è facile poter parlare di sé, ma sento che a volte è proprio questo che manca creando sempre meno spazi di condivisione, di confronto e di aiuto reciproco. Senza la condivisione tra essere umani, che cosa potremmo mai dire di essere? Forse esseri vuoti ma di certo non esseri parlanti e pensanti.
Non sono entrata in un ospedale psichiatrico, ma ho vissuto sulla mia pelle la scarsa empatia nel raccogliere una mente che cade nel baratro, di comprenderla, di attendere che il momento passi. Del rispetto di un percorso terapeutico. Della mia terapia. Da circa un anno mi è stato diagnosticato un disturbo che comporta accelerazione del flusso ideico (e dunque dei pensieri) e organizzativo (rendendo confusa e invalidante la sequenza dell’intera giornata) alternato a episodi depressivi. Fare i conti con una diagnosi non è mai facile, qualsiasi essa sia.
All’improvviso è come una “bomba” che esplode nel modo più distruttivo possibile. Il malessere è emerso un anno prima con episodi di attacchi di panico, poi è “scoppiato” l’intero sistema a causa di un forte senso di colpa per un groviglio di episodi privati che mi hanno coinvolto più di quanto in quel periodo il mio funzionamento poteva reggere.
Quando si attraversa un periodo così buio, le relazioni sono un “antidepressivo naturale”, possono aiutare a far vedere ancora un po’ di luce. Ma accanto a tutto ciò, il sostegno è anche medico, perché volersi bene è complicato. Comporta l’accettazione di cure che in parte spaventano. Proprio perché spaventano c’è tanto bisogno di comprensione e di supporto, ma per me cosi non è stato. Dimenticavo un particolare: vivo in Calabria. Una regione dove avere la depressione significa “etichetta”, “sì pacciu” e non come qualcosa da guarire come qualunque altro disturbo. Vivo in una regione dove molti psicologi non aderiscono al bonus perché l’INPS commette molti ritardi nell’erogazione. Se già ai piani alti c’è sottocultura, figuriamoci tra gli esseri umani che in teoria dovrebbero essere tuoi amici ma hanno già le loro rogne.
E forse è proprio per questo che il mio viaggio dentro l’ospedale psichiatrico della mia anima è stato un delirio fatto di incomprensioni, dove spiegavo i motivi, forse ingigantendoli, perché chi è depresso spesso diventa anche egoista e vede solo il suo dolore, e quindi star vicino a una persona con depressione è difficile. Man mano ho visto allontanarsi persone fondamentali per la mia vita, forse perché non ce la facevano più, forse perché accusavo del mio male questo e quello. E chissà, forse ha ragione chi mi ha detto: “ognuno ha le sue menate; se azzanni tutti ti ritrovi sola”. E ho azzannato e mi sono ritrovata decomposta da sola, come Vanni Fucci divorato dai serpenti nei canti XXIV e XXV dell’Inferno dantesco, condannato a soffrire per sempre perché destinato a ricomporsi e a essere rimangiato.
È un rodersi dentro che fa prendere tutto sul personale, ed i social diventano il tuo colpo al cuore, dove fissi uno schermo piangendo pensando di aver fatto del male a qualcuno senza ragione: certo, non è proprio il luogo ideale da frequentare se soffri di depressione, dove l’80% dei post è una frecciata, un messaggio di rivalsa o vendetta. Ciò che mi ha fatto bene è stato, grazie alla mia terapeuta, staccarmene e non esserne più dipendente come un tempo, e pensare che non tutto sia rivolto a me. Ma è stata dura, e non è stato così scontato che tornassi a casa, tanta era la mia paura di essere giudicata dal prossimo o finire zimbello di un paese di 18mila abitanti dove gran parte della gente mi conosce.
Parlare però delle proprie fragilità non deve essere un tabù, ed ecco che forte è il messaggio di Loredana Bertè, una calabrese come me che in questi giorni sta passando attraverso il canale mediatico più potente che esista in Italia: il Festival di Sanremo. Il suo brano “Pazza” inizia proprio con la difficoltà che hanno avuto gli altri a starle accanto in alcuni momenti: “Sono sempre la ragazza/che per poco già s’incazza/Amarmi non è facile/Purtroppo mi conosco/Ok ti capisco/Se anche tu te ne andrai via da me”
Questa ovviamente, è una canzone, che non può essere legata a una patologia, ma che per me è stata uno specchio di alcune immagini del mio anno di buio. A spezzare una lancia nei confronti di chi non ha compreso posso dire che c’è ancora molta ignoranza e sottovalutazione del problema. Nel mio piccolo, ora che il peggio sta passando, ora che non ho più paura di perdere le persone e che mia madre sa che tornerò a casa anche oggi, e domani e dopodomani, posso mettermi a disposizione e al servizio di chi sta soffrendo come me.
Non sarò Nellie Bly, non sarò Loredana Bertè, ma sono una collaboratrice giornalistica, e anche questa è un’inchiesta. Su me stessa, ma è pur sempre un’inchiesta, che come risultato immediato mi dà il coraggio di essere “pazza di me/ perché mi sono odiata abbastanza”.
Deborah Serratore