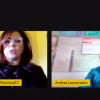Non ci arroghiamo il diritto di parlare di temi giuridici e degli aspetti legislativi della proposta di legge regionale, se non come portatori di interessi e diritti riconosciuti ma non ancora attuati. Sembra giunga emblematica la risposta alla nostra intervista che la professoressa Salazar, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ci ha inviato proprio questa mattina, a ridosso della giornata di ieri, dove in Consiglio regionale è stata ulteriormente rinviata l’approvazione della legge e dove è emerso come evidente che ancora non è chiara l’idea di cosa sia la norma sulla doppia preferenza di genere. Speriamo che l’alto contenuto tecnico ma anche sociale di questa intervista riesca a far comprendere soprattutto alla maggior parte dei consiglieri regionali cosa comporti l’approvazione della norma e i doveri che hanno nei confronti della stessa.
Non ci arroghiamo il diritto di parlare di temi giuridici e degli aspetti legislativi della proposta di legge regionale, se non come portatori di interessi e diritti riconosciuti ma non ancora attuati. Sembra giunga emblematica la risposta alla nostra intervista che la professoressa Salazar, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ci ha inviato proprio questa mattina, a ridosso della giornata di ieri, dove in Consiglio regionale è stata ulteriormente rinviata l’approvazione della legge e dove è emerso come evidente che ancora non è chiara l’idea di cosa sia la norma sulla doppia preferenza di genere. Speriamo che l’alto contenuto tecnico ma anche sociale di questa intervista riesca a far comprendere soprattutto alla maggior parte dei consiglieri regionali cosa comporti l’approvazione della norma e i doveri che hanno nei confronti della stessa.
Riprendiamo qui una delle parti più interessanti dell’intervista, segue il testo integrale del contributo della professoressa Salazar, professore ordinario di Diritto Costituzionale.
Ogni società umana, proprio perché tale, non può che essere attraversata da questa dualità. Ecco, allora, che la presenza delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni politiche – che valgono per l’intera società – non si giustifica perché (come talvolta si sente dire) “le donne devono rappresentare le donne”. Del resto, che non sia così è evidente: il parlamentare, uomo o donna, rappresenta la Nazione, senza vincolo di mandato, secondo l’art. 67 della Costituzione. La presenza delle donne nelle sedi politiche si giustifica, invece, perché esse sono una componente ineliminabile di ogni società. Per questo, la cosiddetta “questione femminile”, in realtà, non è una questione soltanto femminile, ma è una questione che ha a che vedere con la democrazia: che – è bene ricordarlo – è qualcosa che riguarda tutti.
Intervista doppia preferenza di genere e “Quote rosa”
professoressa Carmela Salazar Università Mediterranea di Reggio Calabria
- Nella sua esperienza accademica, nei ruoli assunti a livello nazionale, si è di certo fatta una convinzione della disparità tra quanto prescritto dalle norme e dagli accordi internazionali, dalla nostra Costituzione, dal diritto italiano e quanto tutto questo sia effettivamente attuato rispetto alla parità di genere e alla lotta contro le violenze. Dove, secondo lei, si trova il gap tra attuazione e norme?
La domanda è molto impegnativa. Rinviando le riflessioni sulla parità alle risposte alle domande successive, mi soffermo sulla violenza di genere. Non si tratta di un fenomeno occasionale, né si ritrova solo in contesti di degrado sociale: in media, come è noto, si registra un femminicidio ogni tre giorni. Talvolta si tratta dell’ultimo di una lunga serie di abusi fisici e psicologici iniziati da anni: le aggressioni mortali, spesso precedute da estenuanti strategie persecutorie – il cosiddetto stalking – provengono da un uomo che è, o che è stato, un marito, un compagno, un fidanzato apparentemente “normale”, ma che si è poi trasformato in un torturatore e in un assassino, spesso accecato dalla frustrazione scatenata dalla volontà della vittima di mettere fine alla relazione.
Non ho alcuna competenza per azzardare una qualche spiegazione di questi dati inquietanti e del perché lo stalking e l’assassino del partner siano reati tipicamente (anche se non esclusivamente) maschili. Forse ha ragione Luigi Zoja, decano degli psicoanalisti junghiani, quando sostiene che mentre l’identità femminile appare relativamente stabile nell’evoluzione verso l’homo sapiens sapiens (nel senso che biologia e cultura si sono fuse nella delineazione del ruolo materno, apparendo esso come un prolungamento della funzione naturale di cura, nutrizione ed accudimento dei piccoli), l’identità maschile sembra invece essersi costruita, nel lungo cammino verso l’”umanizzazione”, su due dimensioni non del tutto integrate reciprocamente: la struttura aggressivo-competitiva necessaria alla sopravvivenza dei nostri antenati primitivi ed il ruolo paterno, prodotto dell’evoluzione culturale recente. La tensione tra i due poli, in questa visione, diviene massima dinanzi allo sgretolarsi della famiglia tradizionale ed al venir meno degli schemi sociali (e giuridici) che hanno consentito di non mettere seriamente in discussione, sino ad epoca recente, la struttura patriarcale della società. Come ha precisato lo psicanalista Massimo Recalcati in una recente trasmissione televisiva, una società patriarcale si fonda sulla convinzione della inferiorità ontologica del sesso femminile, e sulla conseguente necessità di “indirizzare” le donne alla loro migliore realizzazione (come è ovvio: esclusivamente quella familiare), nonché di punirle se rifiutano il ruolo per esse considerato ottimale. Si pensi, ad esempio, ai rapporti familiari prima delle riforme degli anni ’70 del secolo scorso, alla lunga sopravvivenza del “delitto d’onore” – cancellato dal nostro codice penale solo nel 1981 – e alla duratura considerazione della violenza sessuale quale reato contro la moralità pubblica e non già contro la persona, come invece è definita attualmente (ma solo dal 1996).
Premesso che, naturalmente, non può discorrersi di automatismi, dovendo sempre distinguersi caso da caso, come non pensare al disorientamento che può avere generato in molti uomini la circostanza che a questi stessi comportamenti violenti e punitivi, negli ultimi decenni, siano state negate in modo sempre più netto l’indulgenza e le giustificazioni di cui erano stati circondati sin dalla notte dei tempi? Come non pensare che tale disorientamento sia divenuto ancora più profondo dinanzi alla crescente affermazione delle donne nello studio e nel lavoro, conquiste che consentono ad esse di riflettere su se stesse e, soprattutto, di bastare a se stesse? Potrebbe allora pensarsi che, in molti casi, la violenza sulle donne – ed, in particolare, l’assassinio di quelle che intendono rompere o non intraprendere una relazione affettiva con l’omicida – divenga il tragico strumento di un folle tentativo di restaurazione del rassicurante “ordine” ormai perduto, per ritrovare il quale l’uomo torna ad essere preda di «qualcosa di molto più primitivo dell’uomo» (L. Zoja, Centauri. Mito e violenza maschile, Roma-Bari, 2010, 6).
Ma, come che sia di ciò, il giurista non può fare a meno di chiedersi cosa possa fare il diritto. La risposta che per prima si affaccia è: il diritto deve punire i responsabili e risarcire le vittime degli atti di violenza (o i loro eredi). Ma è evidente che se questa fosse la sola reazione, si tratterebbe di interventi che si limitano a reagire alla violenza domestica sulle donne ed, in particolare, al femminicidio, senza tuttavia fasi carico della prevenzione del fenomeno e della protezione delle vittime. In Italia, ad esempio, sin dal 2009 vige una legge (la n. 39 di quell’anno), che punisce lo stalking, ma ciò non ha condotto all’abbattimento dei comportamenti persecutori verso le donne. Inoltre, la violenza domestica colpisce anche i figli della coppia, e non solo nel senso che pure questi sono esposti al rischio di subire abusi fisici e psicologici. La violenza sembra infatti trasmettersi tra le generazioni, poiché quella subita o di cui si è stati testimoni da piccoli può aumenta nei bambini il rischio della coazione a riprodurla, una volta divenuti adulti, e – per quanto assurdo possa sembrare – può ingenerare nelle bambine la ricerca di un partner violento.
L’approccio più convincente per il contrasto della violenza domestica è dunque di tipo “olistico”: esso si ritrova nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, eseguita nel nostro Paese con una legge approvata in via definitiva il giorno in cui si celebrava il funerale di una sedicenne barbaramente uccisa dal fidanzato, anch’esso minorenne (l. n. 77/2013).
Non è possibile esaminare esaustivamente il testo di questa importante Convenzione, ma si può ricordare che essa richiede agli Stati coinvolti di adottare le misure necessarie non solo per risarcire, ma anche per proteggere le vittime: dalla messa a disposizione di «un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia», alla creazione di numeri verdi nazionali cui le donne in pericolo possano rivolgersi con la certezza di essere aiutate tempestivamente, all’accoglienza presso rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio anche ai figli. Notevole anche il divieto, per gli Stati sottoscrittori, di favorire l’apertura di alternative al processo giurisdizionale – come la mediazione e la conciliazione – quando la controversia riguardi le forme di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione.
Essa, inoltre, impone agli Stati contraenti di promuovere politiche efficaci volte a favorire in tutti i campi la parità tra le donne e gli uomini e «l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne» (si coglie, qui, un’eco dell’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche per quel che riguarda l’adozione di specifiche misure di vantaggio in favore del sesso femminile, le azioni positive). Ciò, significa, tra l’altro – anche se qui la Convenzione precisa: «se del caso» – che spetta agli Stati intraprendere «le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi». E a diffondere tali progetti anche «nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media». Nel che si coglie la convinzione del Consiglio d’Europa dell’esistenza di una radice (anche) culturale del fenomeno, donde l’auspicio che essa venga combattuto (anche) su questo fronte.
- La legge 20 del 2016, la cui attuazione a breve passerà in Consiglio regionale in Calabria, prevede la parità di accesso alle liste elettorali di uomini e donne. Nell’immaginario popolare vengono chiamate ancora “quote rosa” ma così non è.
La locuzione “quote rosa” è ormai entrata nel linguaggio comune per alludere alle misure di riequilibrio tra uomini e donne, in particolare nell’accesso alle cariche elettive ed a quelle politiche in genere: si tratta di una formula ad effetto, che tuttavia è discutibile, se utilizzata con riguardo all’ambito della politica. In Italia, infatti, non è possibile riservare alle donne (e nemmeno agli uomini) una vera e propria quota di posti nelle liste elettorali.
Per spiegarmi meglio, ricordo brevemente che non solo l’art. 3, primo comma della Costituzione, vieta le discriminazioni fondate sul sesso, ma anche che l’art. 51, primo comma della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, afferma che «Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Infine, ricordo che l’art. 117, settimo comma della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 dispone: «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».
Come afferma la sentenza n. 4/2010 della Corte costituzionale, che ha sancito la conformità a Costituzione della legge della Campania che per prima ha introdotto la doppia preferenza di genere, il quadro ora visto è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell’art. 3, secondo comma della Costituzione, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese. Secondo la Corte, «preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, queste norme indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale».
La stessa Corte, tuttavia, ha affermato che non è possibile perseguire tali doverosi obiettivi attraverso l’inserimento di “misure legislative, volutamente diseguali”, che «possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)», ma che non possono «incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali», tra cui, in particolare, il diritto di elettorato passivo (sentenza n. 422/1995). In materia elettorale, dunque, non è possibile «alcuna misura di “disuguaglianza” allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di “compensare” tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti» (sentenza n. 49/2003). Non è ammissibile, pertanto, una riserva di una quota di posti in lista a favore delle donne (o degli uomini): ecco perché l’espressione “quote rosa”, con riguardo all’accesso alle cariche elettive, appare erronea. Sono invece possibili – ed, anzi, costituzionalmente doverose – le più “miti” misure di riequilibrio (anche definibili come “azioni positive”) che, pur trattando allo stesso modo uomini e donne, sono rivolte a favorire l’accesso di queste ultime alle cariche elettive. La doppia preferenza di genere funziona proprio in questo modo, poiché la seconda preferenza, se si sceglie di utilizzarla, deve essere data per un candidato di sesso diverso rispetto a quello cui è andata la prima preferenza: può dunque andare a una donna o un uomo, a seconda dei casi.
La formula “quote rosa”, perciò, si presenta più adatta a definire il meccanismo introdotto dalla legge n. 120/2011 (la cosiddetta legge Golfo-Mosca): per assicurare l’equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate in borsa, l’art. 1 della legge prescrive che il sesso sottorappresentato debba ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Siamo qui in un campo che non ha nulla a che vedere con quello della rappresentanza politica: il raggio d’azione del legislatore è dunque più ampio, non entrando in gioco i princìpi costituzionali in materia di elettorato attivo e di elettorato passivo.
Vorrei, infine, chiarire un punto. Molte donne sono perplesse dinanzi alle misure di riequilibrio ed alle “quote rosa”, perché ritengono che si tratti di interventi inutili o addirittura stigmatizzanti, in quanto presupporrebbero l’incapacità delle donne di “farcela da sole”. Ma è vero proprio il contrario.
In primo luogo, tali interventi non sono previsti in ambiti in cui le donne hanno mostrato ampia capacità di affermarsi senza nessun “aiuto”: infatti, se la “competizione” avviene secondo regole basate davvero sul merito, non c’è bisogno di intervento alcuno, perché le donne arrivano tranquillamente dove devono arrivare. Penso, ad esempio, alla magistratura e all’avvocatura, cui si accede attraverso un concorso pubblico: il numero delle donne è addirittura superiore a quello degli uomini.
In secondo luogo, le misure di riequilibrio, le azioni positive e le “quote rosa” non muovono dalla convinzione che le donne siano incapaci, ma dalla constatazione che esiste un pregiudizio sociale sulla loro incapacità. Le misure di riequilibrio nel campo della politica intendono rendere più facile alle donne il raggiungimento di una meta che altrimenti esse, come mostrano le statistiche, non raggiungerebbero o che raggiungerebbero con maggiore difficoltà, pur quando abbiano tutte le carte in regola. Il problema, infatti, nasce quando il meccanismo di selezione tra uomini e donne non è basato sul merito, ma sulla cooptazione esercitata dagli uomini: i numeri tuttora esigui delle presenze femminili nella politica, nazionale e locale, parlano da soli. Le azioni positive in materia elettorale e le “quote rosa” nelle società quotate in borsa funzionano dunque come correttivo di un trend che, in assenza di tali interventi, continuerebbe a perpetuare la prevalente presenza maschile nei luoghi della politica o nei consigli di amministrazione. Lo scopo è quello di permettere alle donne di mostrare ciò di cui sono capaci in ogni possibile ruolo, compresi quelli tradizionalmente “maschili”. Dunque, si tratta di misure che mirano a distruggere il pregiudizio sulla presunta “inferiorità” delle donne, non certo a confermarlo. È lasciando le cose come stanno che si avalla l’idea della inidoneità del sesso femminile a ricoprire incarichi politici, e non certo consentendo alle donne di arrivare a ricoprire quei ruoli, così che esse possano mostrare che sono capaci quanto gli uomini, se non di più.
Altra cosa è sostenere che i meccanismi di riequilibrio in materia elettorale, purtroppo, non bastano. Come affermato dalla Corte costituzionale, al riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica «si può […] pervenire con un’intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l’effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare» (sent. n. 422/1995). Norme come quelle sulla preferenza di genere nella legge calabrese sono senz’altro importanti, eppure dobbiamo essere consapevoli che esse «possono solo offrire possibilità di scelta aggiuntive agli elettori, ma non garantiscono – né potrebbero farlo – che l’obiettivo sia raggiunto, giacché resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse, potrebbero frustrare l’intento del legislatore regionale, perpetuando la situazione esistente, che presenta un vistoso squilibrio di genere nella rappresentanza regionale e, più in generale, nelle assemblee elettive della Repubblica italiana» (sent. n. 42010).
- Nuove proposte parlano di quota obbligatoria del 50 per cento di candidati nelle liste e di unica preferenza al voto, invece dell’alternanza dei due sessi. Si può ravvisare così ad un ritorno alle “quote rosa”
Come ho ricordato nella risposta precedente, la Corte costituzionale ha detto chiaramente che la doppia preferenza di genere è una misura del tutto coerente con la Costituzione ed ha anche precisato che, nel campo della rappresentanza politica, lo strumento delle azioni positive va utilizzato con cautela, perché non sono ammissibili “misure volutamente disuguali” a favore di uno dei due sessi. Mi chiedo, allora: perché proporre una soluzione ad alto rischio di incostituzionalità (la quota obbligatoria del 50%), e non quella sicuramente conforme alla Carta del 1948 (la doppia preferenza di genere)?
- Secondo lei, l’ingresso paritario delle donne nelle istituzioni può portare ad un miglioramento delle stesse attività istituzionali in termini di ampliamento dell’orizzonte normativo? Laddove nelle scelte di apertura in settori privati, come le società partecipate, il dato conferma la maggiore crescita economica delle stesse aziende?
Uno psicologo o uno psichiatra potrebbe rispondere meglio di me in ordine alla “specificità” dell’apporto femminile alle decisioni politiche. Non mi soffermo, perciò, su questo profilo – peraltro, molto interessante – quanto su un altro aspetto della domanda. Dal punto di vista del diritto costituzionale, infatti, la necessaria presenza di entrambi i sessi nei luoghi della politica non è legata (soltanto) alla prospettiva di una (auspicabile) più attenta ponderazione del complesso degli interessi di cui, di volta in volta, chi decide deve tenere conto. Se ragioniamo un momento sull’etimologia della parola “sesso”, ci accorgiamo che essa viene dal latino “secare”: la dualità maschile-femminile taglia in due l’umanità. Le donne, perciò, non appartengono ad un “gruppo” o ad una minoranza, ma sono una connotazione dell’umanità. Ogni società umana, proprio perché tale, non può che essere attraversata da questa dualità. Ecco, allora, che la presenza delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni politiche – che valgono per l’intera società – non si giustifica perché (come talvolta si sente dire) “le donne devono rappresentare le donne”. Del resto, che non sia così è evidente: il parlamentare, uomo o donna, rappresenta la Nazione, senza vincolo di mandato, secondo l’art. 67 della Costituzione. La presenza delle donne nelle sedi politiche si giustifica, invece, perché esse sono una componente ineliminabile di ogni società. Per questo, la cosiddetta “questione femminile”, in realtà, non è una questione soltanto femminile, ma è una questione che ha a che vedere con la democrazia: che – è bene ricordarlo – è qualcosa che riguarda tutti.
Vorrei concludere riprendendo una notazione della prof.ssa Marta Cartabia, attuale Vicepresidente della Corte costituzionale: abituandoci a “vedere” e a rispettare la diversità che nasce dalla dualità maschile-femminile, diventiamo disponibili a “vedere” e a rispettare anche le altre diversità. Un’abitudine che non dovrebbe mai perdersi e che, particolarmente in questo momento storico, dovrebbe essere coltivata con assiduità da chi ha a cuore la democrazia.